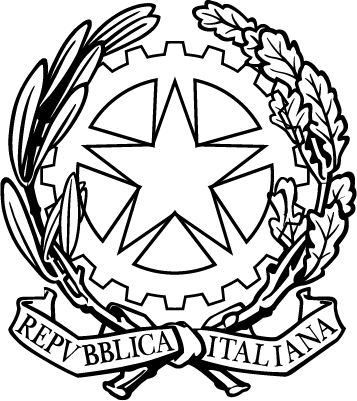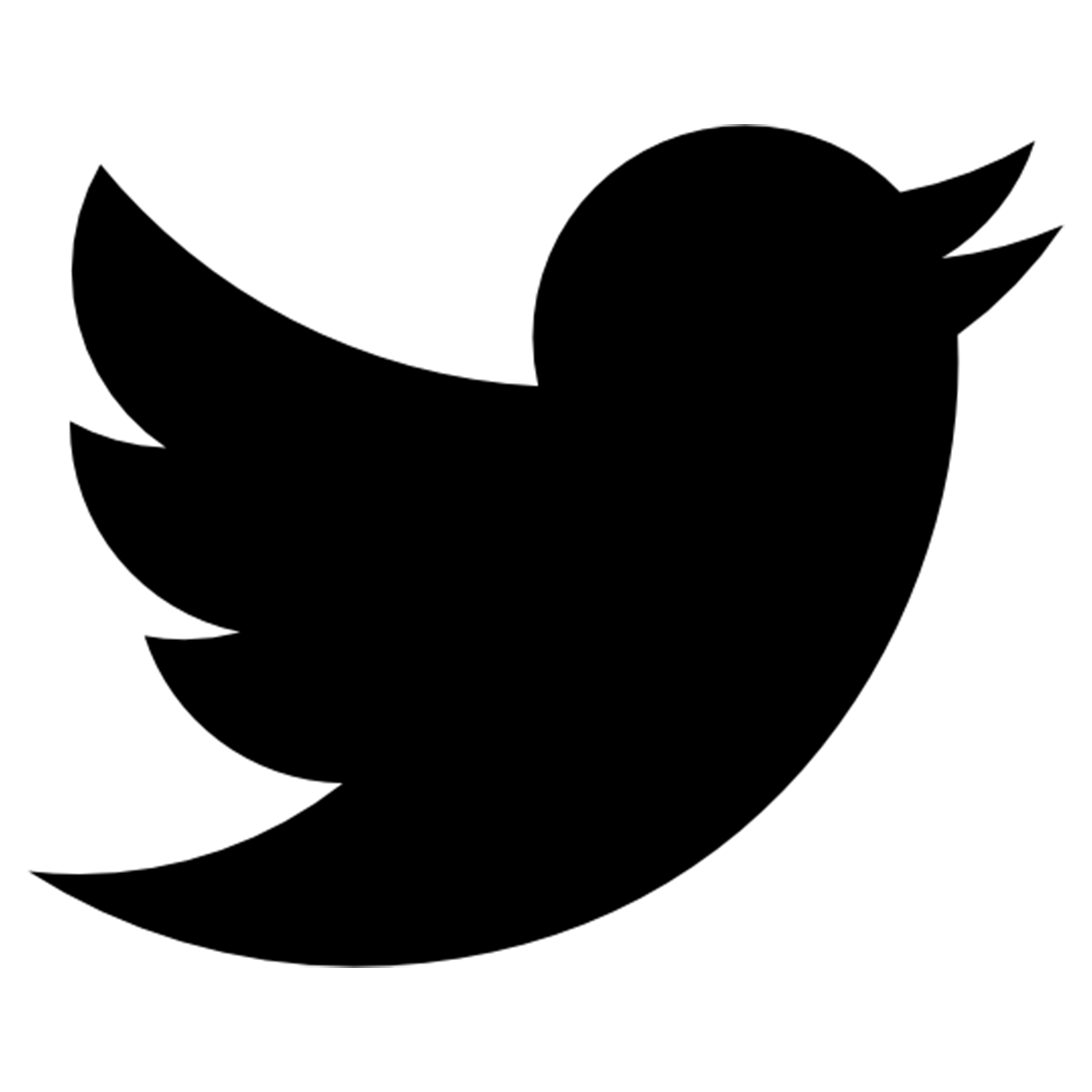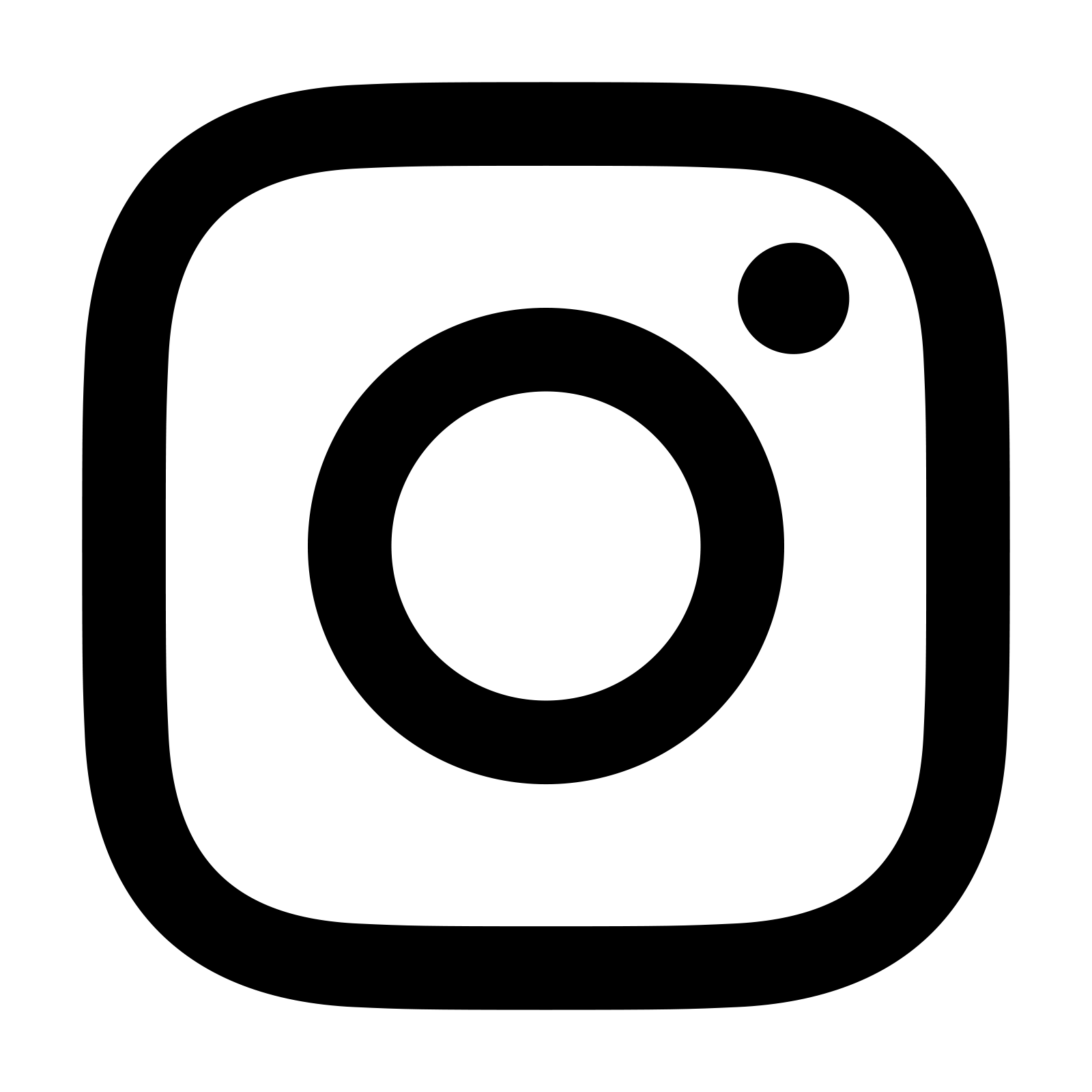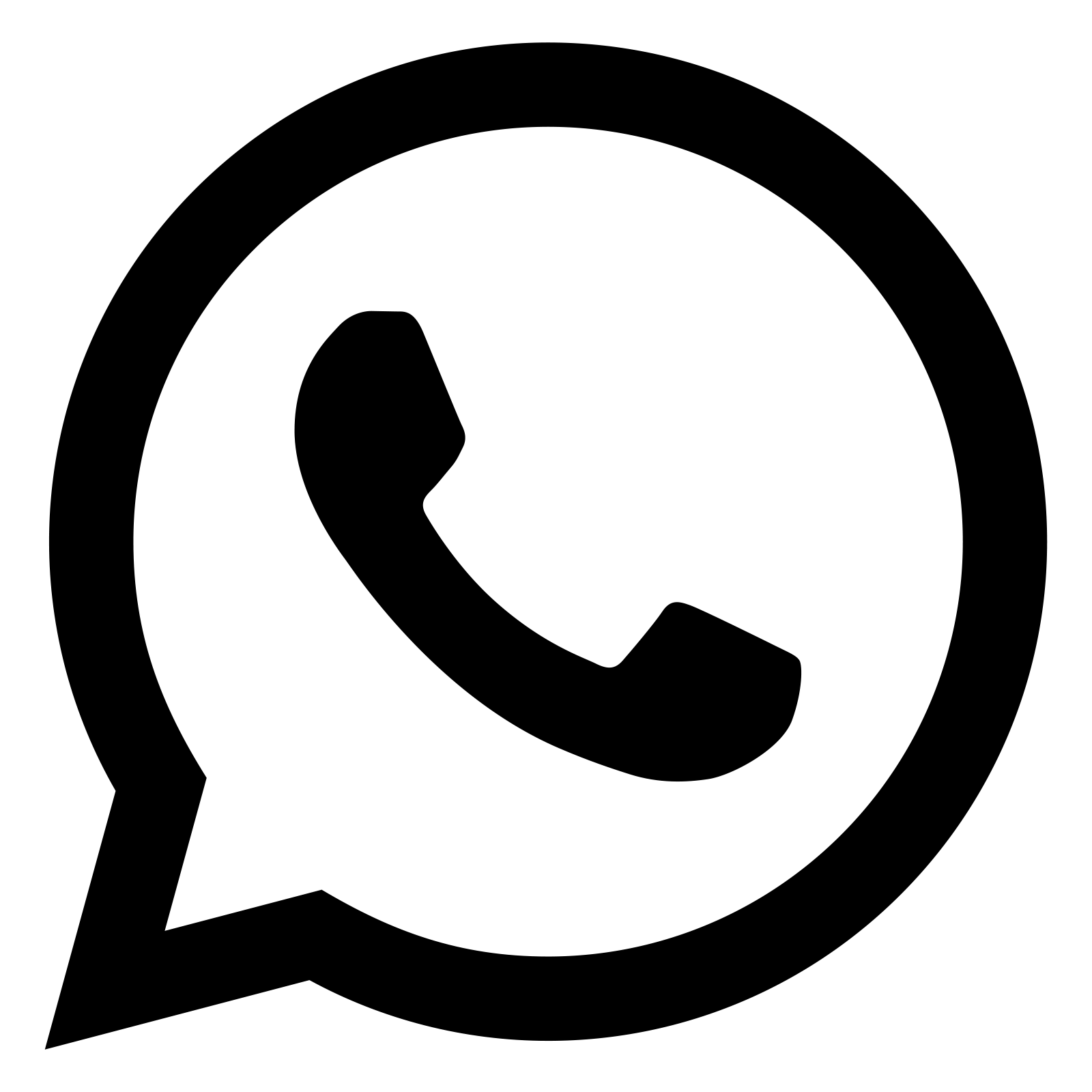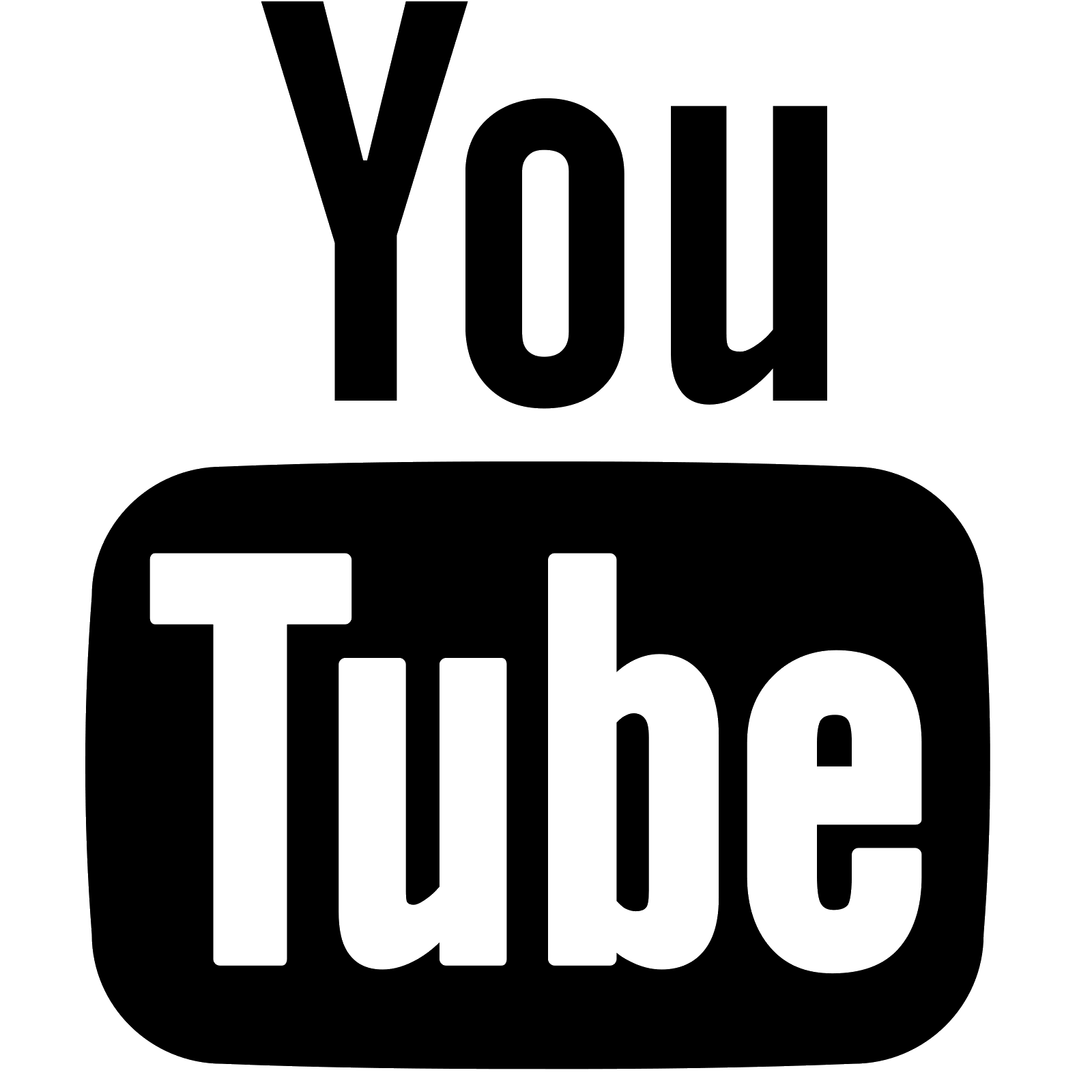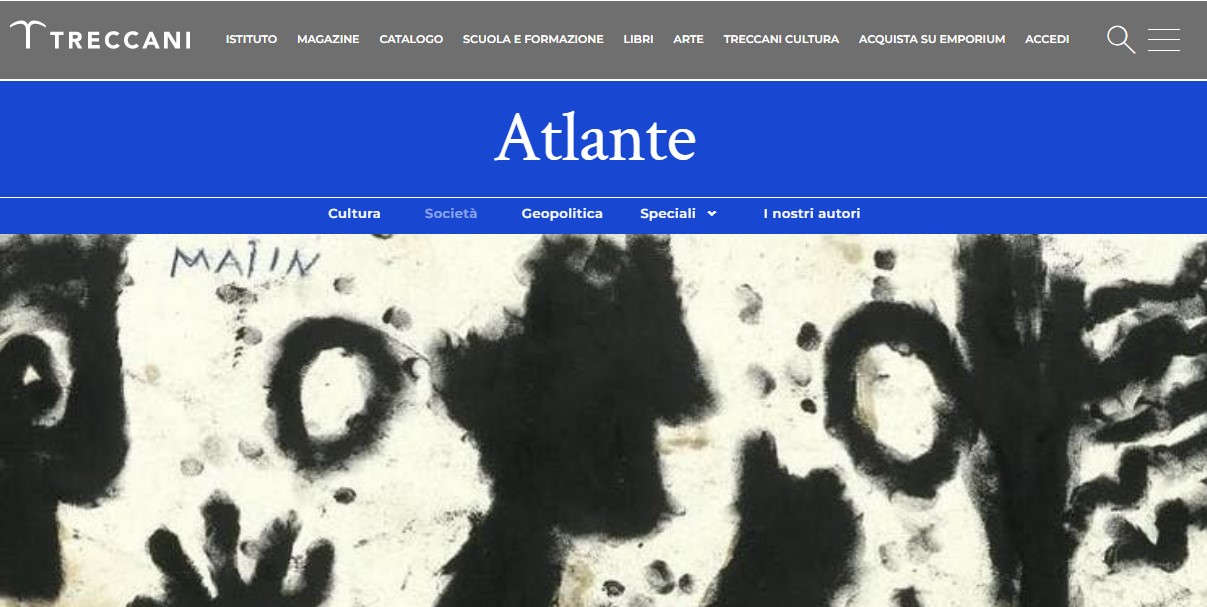Quasi in un moto oscillatorio, con l’impeto di un’onda e della successiva risacca, la tortura irrompe nella scena pubblica, attrae un dibattito animoso per alcuni giorni e poi si cela nuovamente, sparisce dall’attenzione dei media e dalla discussione pubblica. Questo suo ritrarsi autorizza i disattenti commentatori e gli ancor più disattenti rappresentanti politici a negarne l’esistenza, relegando quel suo presentarsi a episodio eccezionale, frutto dell’azione di pochi, ristretto alla responsabilità di qualche “mela marcia”. Invece la tortura continua la sua persistenza – anche vivendo talvolta in modo carsico – perché continua il ricorso a essa, nonostante le molte affermazioni roboanti di assoluto rifiuto, nonostante l’esistenza di Convenzioni sottoscritte a livello internazionale nonché l’impegno dichiarato a intervenire per punire le poche “mele marce” che se ne possano essere rese responsabili.
Negli anni recenti, sul piano internazionale, è divenuta visibile anche nei telegiornali all’ora di cena, attraverso l’orrore di Abu Ghraib e attraverso le oscene difese, fatte da responsabili statunitensi di altissimo livello, di tecniche di interrogatorio centrate sulla sensazione di soffocamento – il cosiddetto waterboarding – non classificate come pratiche di tortura. Non sono stati i soli; su altri scenari, per esempio nella repressione dei movimenti nazionalisti in Cecenia, le denunce di tortura sono divenute consuete, mentre sulla spinta della lotta al “terrorismo internazionale” si affermava un po’ dappertutto un linguaggio denso di termini nuovi che diminuivano l’impatto di queste pratiche inconfessabili: renditions, per indicare l’invio di persone verso Paesi dove sarebbero state interrogate in modo sbrigativo, secret flights per voli non tracciabili secondo le usuali modalità e anche secret places dove le persone sospettate di vicinanza al terrorismo, ma non formalmente imputate, venivano trattenute fuori da quel controllo che solo il rigore della procedura formale può garantire. Tutto ciò è avvenuto in un attimo, all’indomani di qualche affermazione avventata di chi – ricordo bene un dibattito nel nostro Paese – parlava della tortura come di una pratica antica, ormai bandita nei Paesi avanzati e rimasta in qualche anfratto del nostro globo definito ancora indietro nel percorso verso la presunta civiltà democratica.
Certamente il suo improvviso riapparire era anche il frutto della tragedia del settembre 2001 e dello sgomento del mondo intero rispetto all’attacco a quelle torri che rappresentavano nell’immaginario una esplicita concretizzazione del progresso, della tecnologia e della civiltà occidentale. Ed è vero che l’insorgere del conflitto esplicito e di un attacco di dimensione inimmaginabile è stato il terreno del ritorno alla visibilità della tortura e ha anche rinverdito un ambiguo dibattito sull’assolutezza del suo rifiuto, in qualsiasi circostanza, e sulla possibilità, al contrario, di regolamentarla. Un dibattito che ha finito col coinvolgere, soprattutto oltreoceano, perfino alcuni esponenti di supposta tradizione democratica. Così come è vero che essa si manifesta frequentemente nel contesto bellico e, ancor più, in quello postbellico, quando le parti avverse impropriamente tendono a regolare i precedenti conti. Tutto ciò è vero, ma non basta per comprendere la persistenza della tortura e sarebbe sbagliato restringere a questi scenari il suo periodico riaffacciarsi.
In realtà, la tortura torna a presentarsi ogniqualvolta si stabilisce una irriducibile negazione dell’altro, e ciò avviene anche in situazioni non formalmente conflittuali. L’abbiamo vista a Genova nel luglio 2001, come poi anche alcuni atti processuali hanno ben documentato. Ma quel luglio genovese era stato preceduto dagli episodi di grave maltrattamento, ben leggibili come tortura, agli esiti di una manifestazione napoletana del marzo dello stesso anno e, andando indietro di una decina di mesi, dal pestaggio delle persone detenute nel carcere San Sebastiano di Sassari. Episodi di gravissimo maltrattamento e tortura, pur in situazioni ben diverse da quelle di uno scenario bellico, agiti nei confronti di persone fermate, quando chi è responsabile, seppur temporaneamente, della loro libertà, non riconosce nella loro soggettività caratteristiche di appartenenza allo stesso consorzio umano, ma soltanto un’irriducibile alterità, quasi la rappresentazione di un male assoluto capace di aggredire, per il fatto stesso di esistere la propria dimensione esistenziale.
«Uno specchio negativo che proietta attraverso l’immagine del fermato o del detenuto tutto ciò che colui che lo detiene vuole abbattere. Per questo il custode vuole annientarlo con un’umiliazione che degradi la sua umanità e gli permetta di non sentirsi più aggredito dalla sua esistenza; oppure con la capacità di ottenere da lui stesso la conferma della sua minorità, o richiedendogli di aderire a informazioni già definite o confinandolo al ruolo di delatore. Così la tortura e il trattamento inumano o degradante si ripresentano periodicamente non solo nelle situazioni di guerra, dove l’inimicizia è sancita, ma anche nei conflitti non formalizzati, e però densi di odio etnico, o nelle situazioni di tensione pur in normali operazioni, quando la persona detenuta o il suo gruppo di appartenenza vengono vissuti come nemico assoluto in grado di aggredire la stessa identità, individuale o collettiva, di chi lo detiene»: ho ripreso queste frasi dal mio commento all’indomani delle informazioni avute di ciò che era successo nella caserma di Bolzaneto a Genova, dove – come si accerterà successivamente – persone ormai sotto controllo, private della libertà, erano state oggetto di brutali pratiche da parte di chi le deteneva e, quindi, era responsabile, in nome della collettività, del rispetto del loro intangibile diritto alla propria dignità e alla propria incolumità fisica e psichica.
Ma a quelle immagini se ne sono aggiunte altre nel corso dei venti anni che ci separano da allora: le ultime le hanno mostrate, anche in questo caso con ampia diffusione, le registrazioni video nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, soltanto due anni fa. Al di là delle responsabilità specifiche sul piano penale delle singole persone che proprio quelle immagini colgono nell’atto di operare, resta la cultura che esse esprimono: non sono immagini di una violenza “reattiva” leggibile come incapacità a saper affrontare le tensioni che in tali luoghi non mancano; sono immagini di una spedizione volta a umiliare le persone, a offendere la loro dignità, ponendole in ginocchio, picchiandole mentre sono in situazione di chiara sudditanza e di impossibilità di difesa. In sintesi, l’immagine chiara di quel rapporto di volontà di annientamento e di riaffermazione del proprio potere.
Episodi di questo tipo non hanno trovato nel passato recente – inclusi quelli di Genova – una reazione punitiva adeguata nel nostro Paese, perché, pur avendo ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura sin dalla fine degli anni Ottanta e, quindi, sottoscritto l’obbligo a perseguire adeguatamente tali comportamenti, non si era mai introdotta nel codice penale una fattispecie specifica rubricata come “tortura”. Il nostro sistema penale perseguiva tali atti ricorrendo a ipotesi incriminatrici più deboli – dalle lesioni aggravate all’abuso di autorità contro arrestati o detenuti, alla violenza privata – che, oltre a non rendere esplicita la gravità intrinseca della tortura, sono soggette a breve prescrizione. Da qui, le diverse condanne del nostro Paese da parte della Corte di Strasburgo, per aver violato quell’obbligo inderogabile contenuto nell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani che vieta maltrattamenti e tortura e che implica il corrispondente obbligo a indagare adeguatamente i casi di supposta tortura e, se accertati, a sanzionare adeguatamente i responsabili.
Questo è il contesto in cui è maturata la necessaria introduzione di un reato specifico nel codice: un percorso lungo, durato più di trent’anni, con molti interlocutori che ritenevano – e tuttora forse ritengono – che l’opacità giovi all’azione delle Forze di polizia e che un reato specifico costituisca un attacco al loro operare, non capendone invece il valore intrinseco proprio quale criterio distintivo tra l’azione della stragrande maggioranza che opera correttamente e quella di coloro che offendono il valore costituzionale della propria divisa. Soprattutto non capendo come il valore culturale dell’introduzione di quel reato – quantunque formulato in modo “claudicante” dal punto di vista linguistico e da quello della sua stretta aderenza alla definizione della tortura consegnataci dalle Convenzioni internazionali – costituisca un passo importante per la pienezza dei diritti di ogni persona e per il profilo democratico del nostro ordinamento. Le inchieste di questi anni, dopo la sua approvazione nel 2017, danno conferma dell’importanza della scelta fatta allora, approvando un testo che è, comunque, di mediazione e che costituisce la base per l’azione della magistratura verso la costruzione di una giurisprudenza pienamente aderente alla configurazione internazionalmente definita della tortura.
Per questo, la tardiva conquista non può vedere passi all’indietro. E la discussione, piuttosto sciatta, che qualcuno ha recentemente sollevato per ritoccare la norma perché rischierebbe di diminuire l’incisività degli strumenti d’indagine delle Forze di polizia, ha l’inaccettabile retrogusto della richiesta di “mani libere” e di un ritorno al passato. Anche il versante più raffinato della discussione, introdotto dal ministro della Giustizia nel rispondere in Parlamento a una specifica domanda e tendente a trasformare il dolo generico – così come ora è previsto – in dolo specifico – con l’indicazione della motivazione e della finalità dell’infliggere sofferenza e umiliazione – è attualmente improprio e prematuro. Saranno solo l’impiego della norma per un certo numero di anni, la sua capacità nella repressione e nella prevenzione di comportamenti violenti e gli esiti dei dibattiti nelle aule di giustizia a indicare la necessità o meno di un qualsiasi intervento emendativo.
di Mauro Palma, Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
Immagine: Louis Soutter, Matin (Apocalypse-Rückseite), 1937-42. Crediti: Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Sammlung Moderne Kunst in der Pinakothek der Moderne München [Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)], attraverso www.sammlung.pinakothek.de