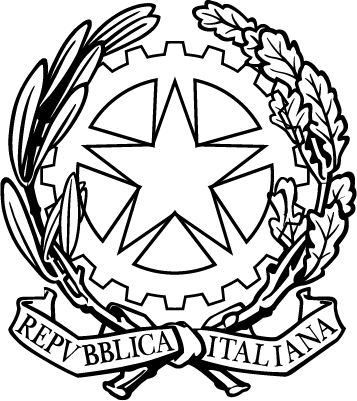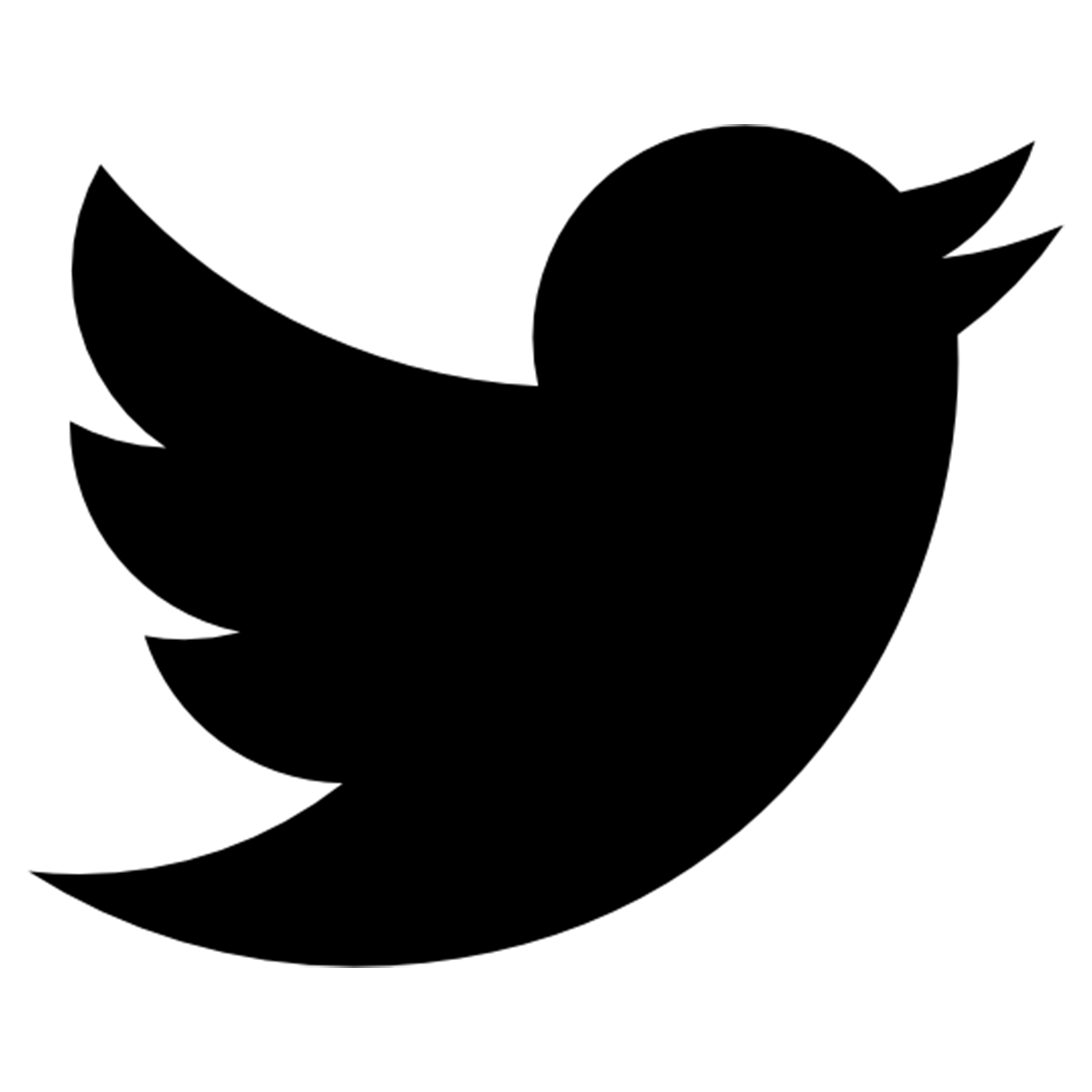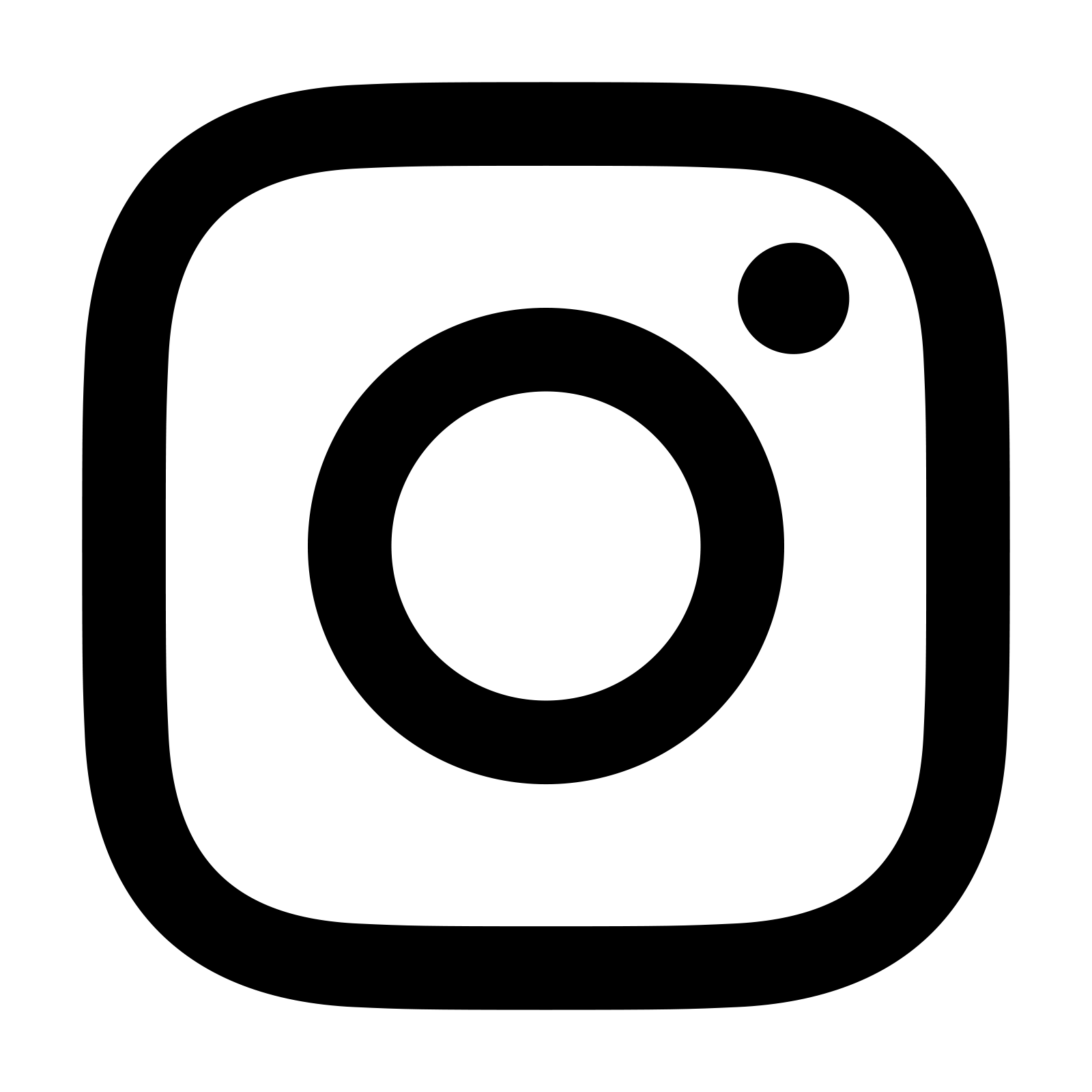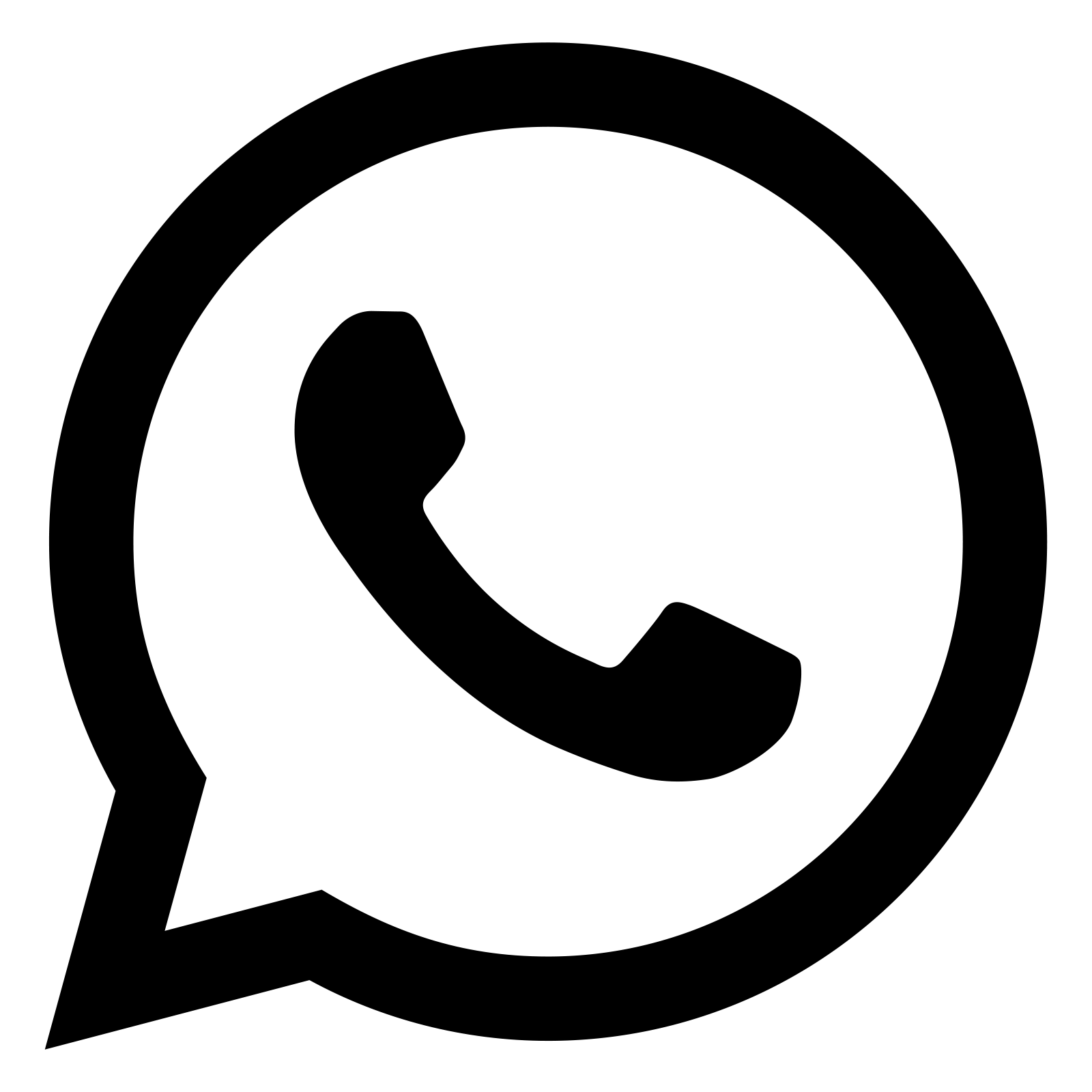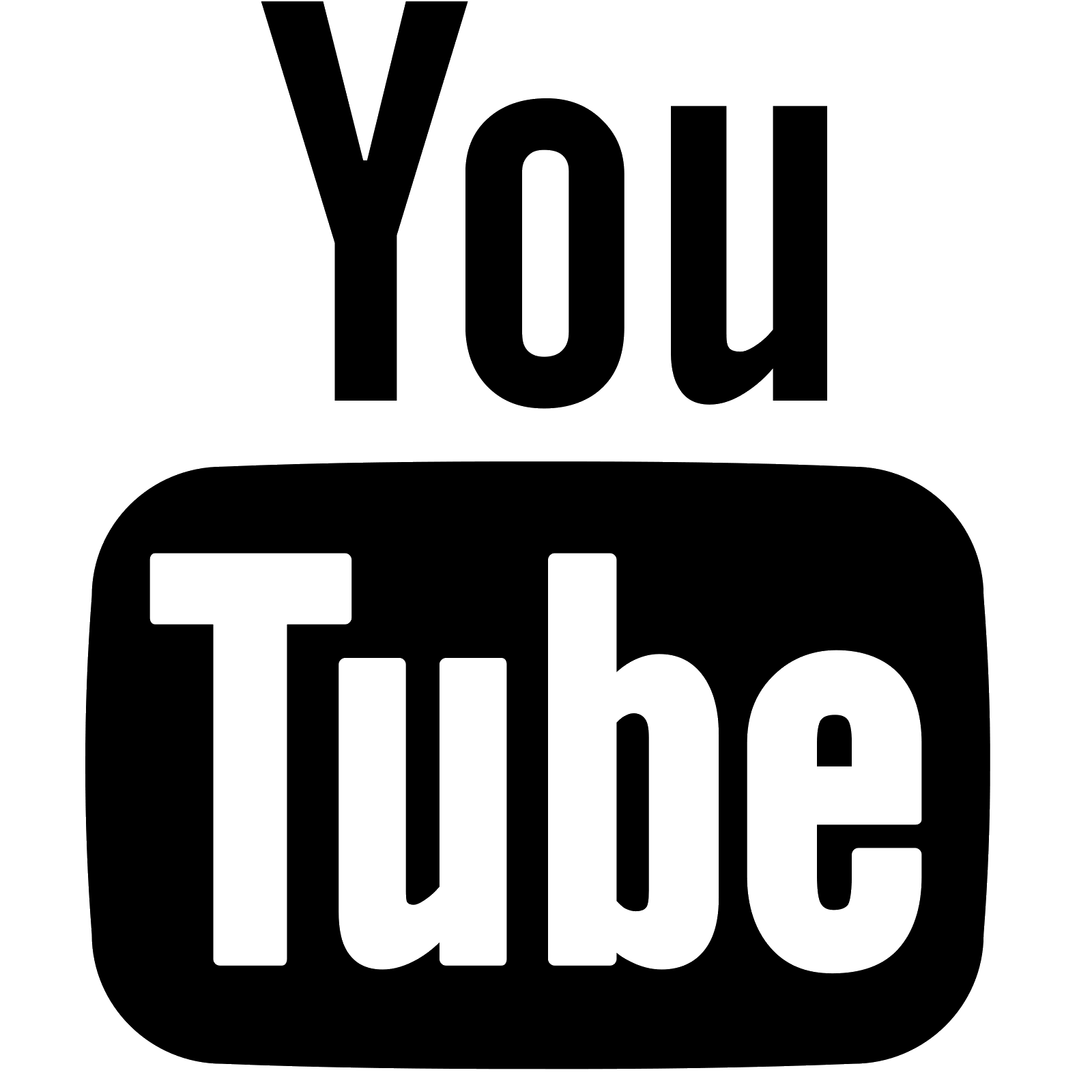«La laurea conseguita durante la detenzione e la frequentazione di un master per giurista di impresa, ove si consideri la sua personalità per come emerge dalle relazioni di sintesi, si ritiene possano aver affinato le sue indiscusse capacità e gli strumenti giuridici a sua disposizione per reiterare condotte illecite in ambito finanziario ed economico, che possono essere svolte anche se ristretto in detenzione domiciliare».
Questa frase compare, nero su bianco, nella motivazione, da parte di un tribunale di sorveglianza, del rigetto di una istanza di differimento della pena per motivi di salute o, in via subalterna, di detenzione domiciliare. Erano i primi giorni di chiusura del 2020, quelli dell’ansia della diffusione del virus, particolarmente sentita nei diversi luoghi di privazione della libertà personale e soprattutto in carcere. Il detenuto aveva richiesto tale misura sulla base di un’asserita situazione di fragilità sanitaria che lo rendeva particolarmente esposto alle conseguenze di un eventuale contagio.
Non interessa qui la sussistenza o meno di tali presupposti, né voglio avanzare alcun giudizio circa la decisione del magistrato: non è questo il tema. Ciò che fa invece sobbalzare sulla sedia è che in un provvedimento di un tribunale di sorveglianza di una città detta la Dotta, quale è Bologna, si legga che gli studi universitari, la laurea e addirittura il post-laurea possano essere fattori potenzialmente pericolosi in grado di affinare la capacità criminale della persona detenuta. L’istruzione, la cultura, quindi, non come elementi di concretezza per quel percorso che dovrebbe rispondere alla finalità delle pene, come indica la nostra Carta. No, vengono qui interpretate come elementi di una possibile accresciuta capacità di commettere reati.
Questo aspetto ci interroga perché estensivamente potrebbe applicarsi anche al di fuori del carcere: maggiore l’istruzione, più raffinata la possibilità di delinquere, soprattutto in alcuni ambiti di attività, come appunto quelle legate all’economia. Da qui, la necessaria indignazione, che ha coinvolto il Dipartimento universitario dove il giovane detenuto ha studiato, giuristi e docenti e che ha portato il Presidente emerito della Corte costituzionale, Giovanni Maria Flick, a presentare, insieme alla avvocata Francesca Cancellaro, ricorso alla Corte europea dei diritti umani. Per violazione dell’articolo 2 del primo protocollo integrativo della Convenzione che prevede il diritto allo studio, e di altri articoli importanti per gli effetti che tale affermazione può determinare in chi ha impostato il proprio percorso di detenzione in termini di riscatto, anche attraverso lo studio per un futuro positivo reinserimento nella società.
Dietro c’è il persistere di una impostazione culturale (e ideologica) che non investe realmente sull’istruzione quale veicolo di un ritorno positivo alla collettività, ma che vede l’accesso allo studio come una sorta di privilegio e la presenza in carcere di una istituzione universitaria quale un ospite, anche gradito, ma mai compartecipe a tutti gli effetti di un progetto di positiva esecuzione penale. Invece ci sarebbe bisogno di un investimento massiccio proprio sull’istruzione: è vero in carcere ci sono più di milleduecento detenuti che frequentano l’università - e questo è un dato positivo - ma ce ne sono quasi altrettanti analfabeti e più di cinquemila che non superano il livello di istruzione elementare. Un dato che richiama la responsabilità anche di chi si esprime in quei termini sul “pericolo” rappresentato dall’impegno nello studio.