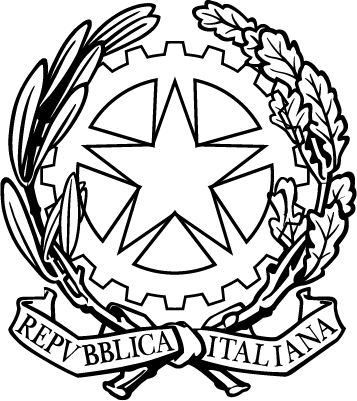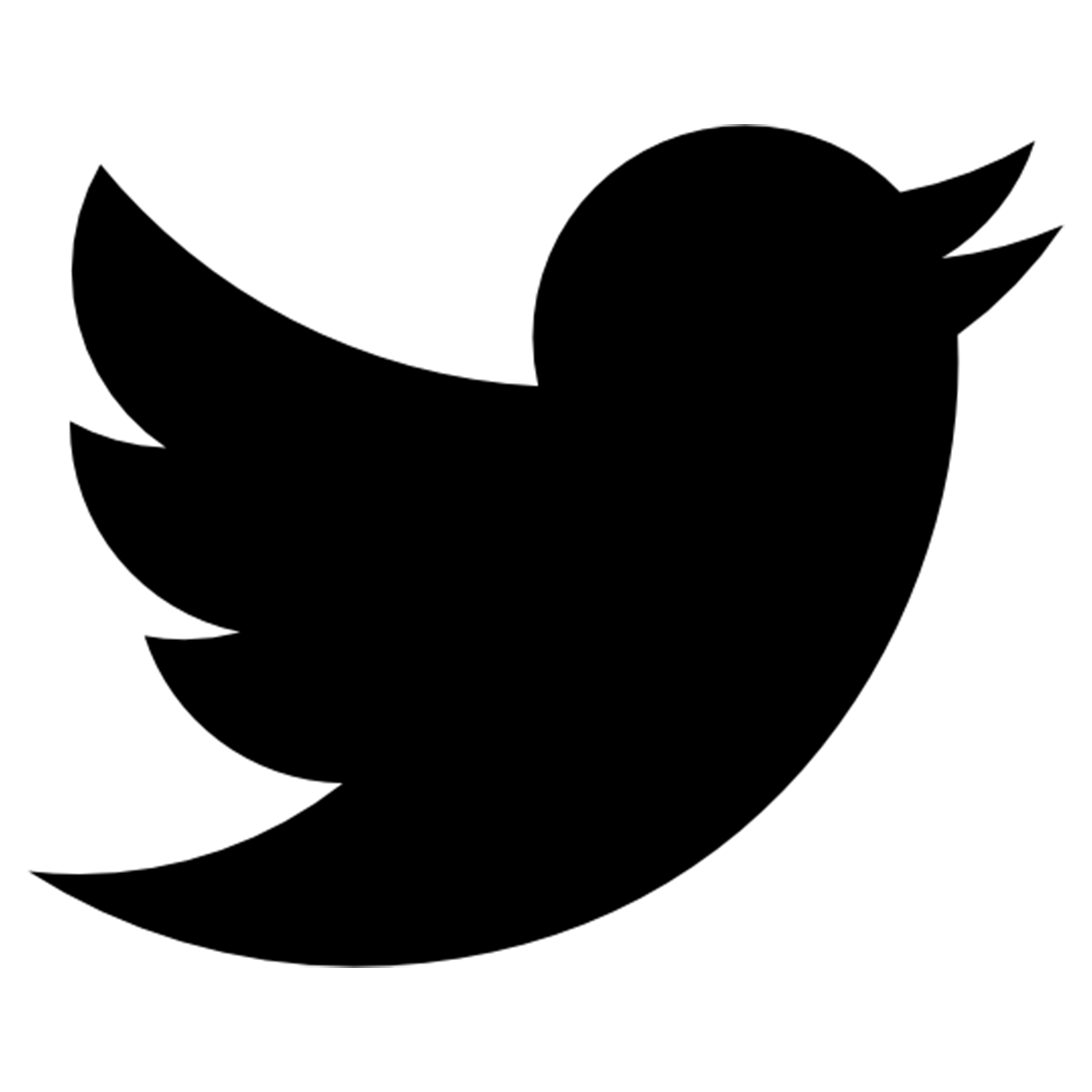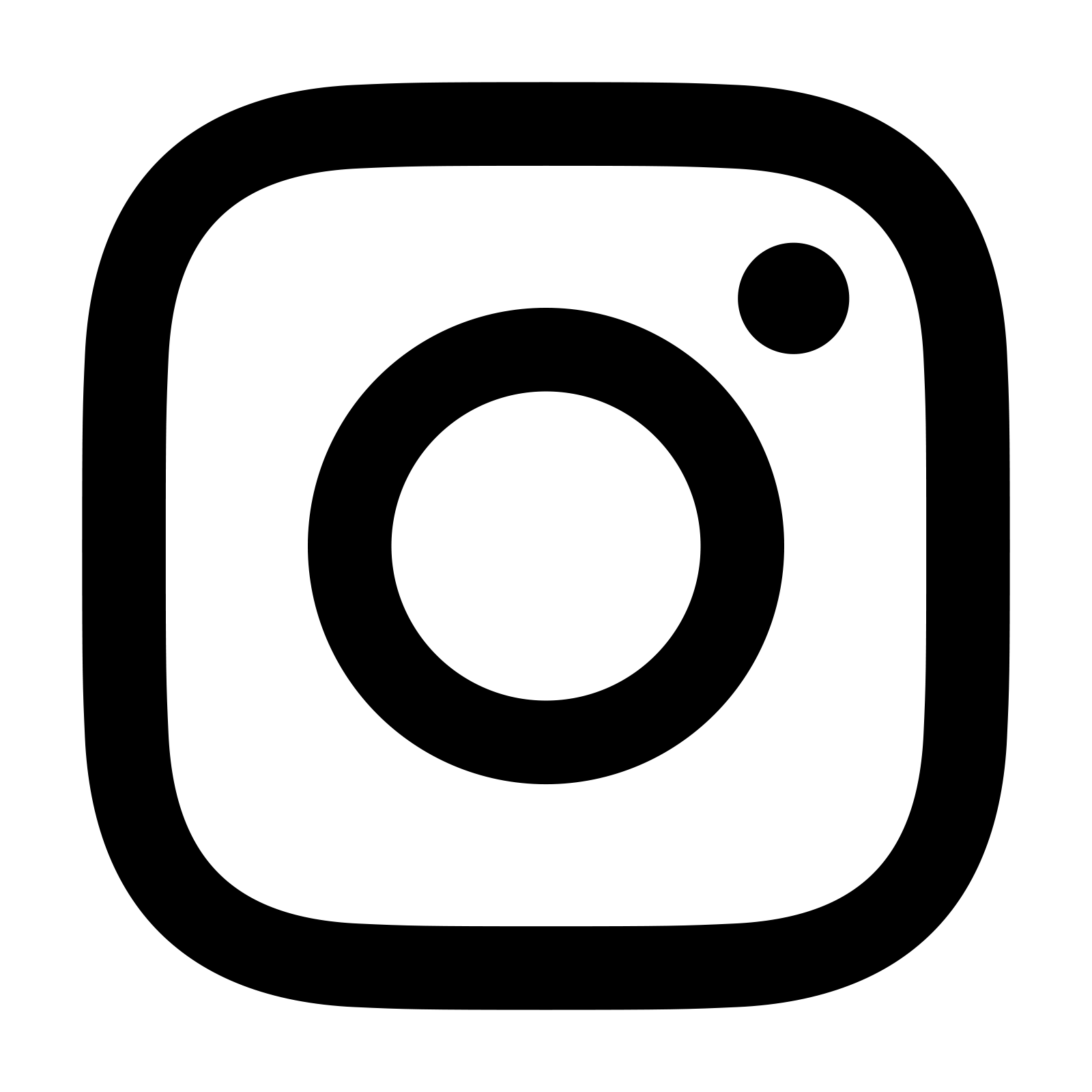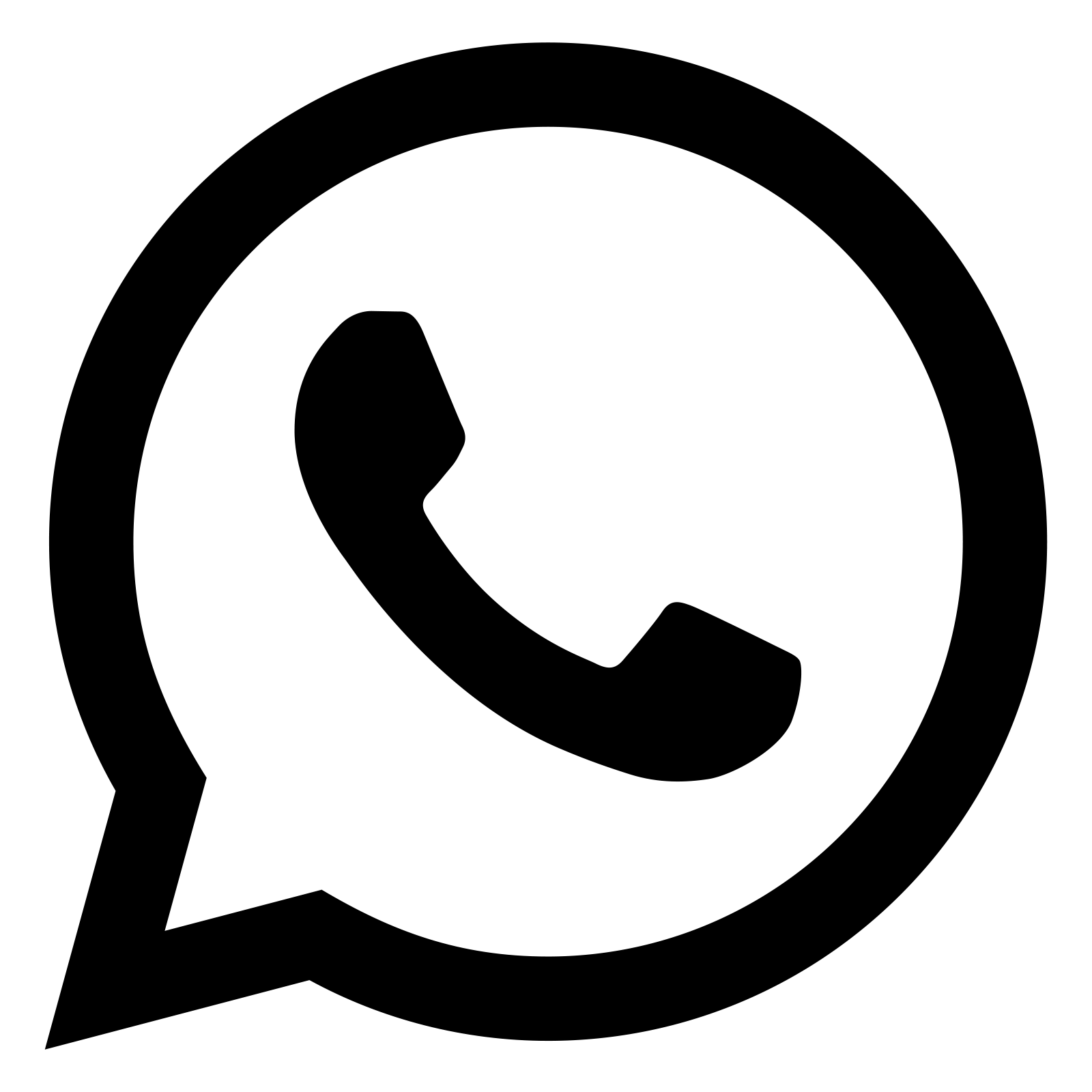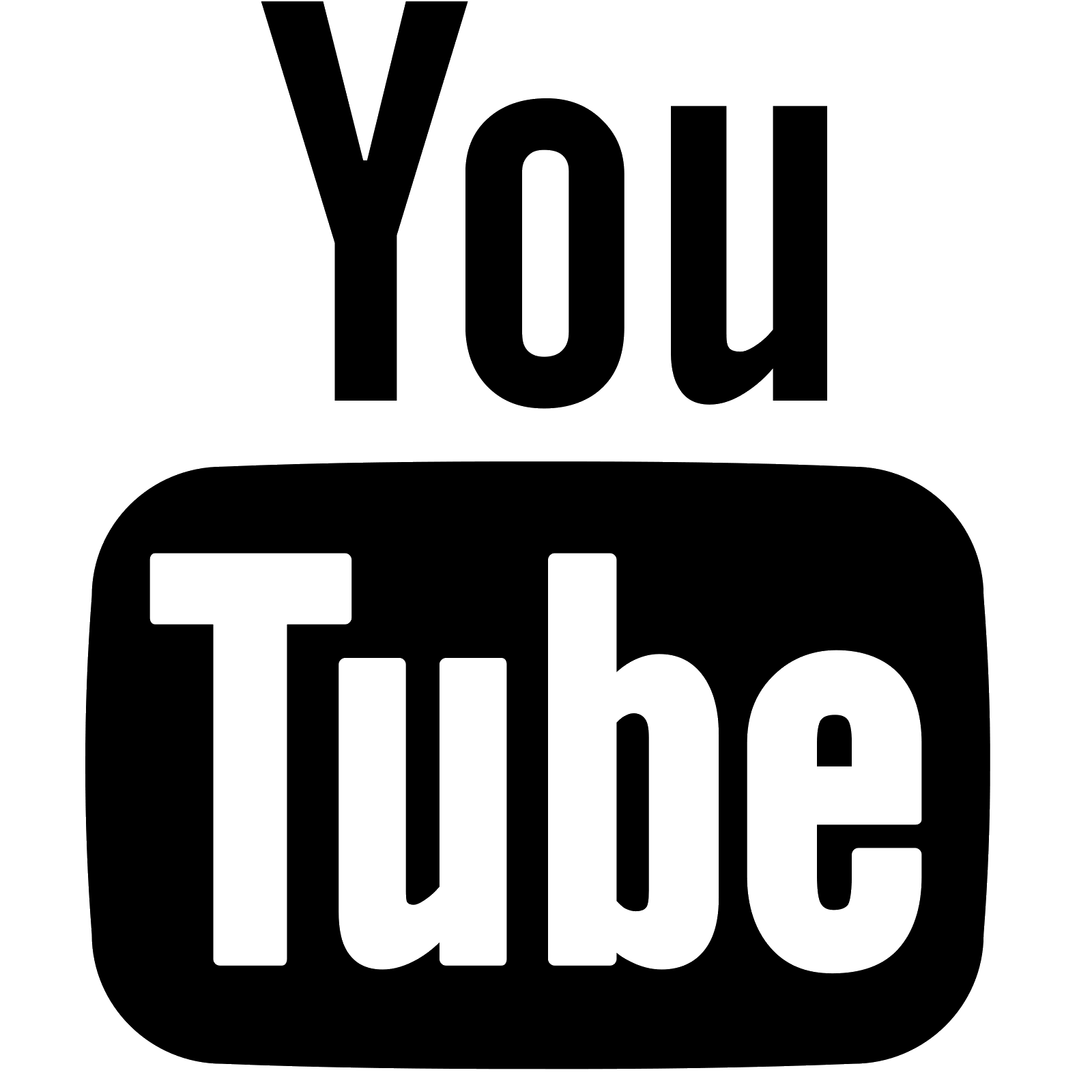I diritti delle persone private della libertà, conferenza istituzionale di Mauro Palma
Ringrazio l’Accademia dei Lincei, la sua Presidenza e gli altri Organi per l’onore dell’invito a tenere una conferenza proprio in questo luogo, paradigmatico della nostra più alta tradizione culturale e della sua connessione internazionale, su un tema che riguarda quelle persone che spesso sono ai gradini più bassi dell’attenzione pubblica e della capacità di lettura dei loro incomprimibili diritti. Un mondo frequentemente visto come separato dall’altro, quello della cosiddetta normalità regolatrice dei comportamenti della maggioranza non deviante e soprattutto visto come foriero di complessità, senza la capacità di leggere in esso lo specchio di altre complessità che coinvolgono chi è al di qua del muro che vorrebbe separare i due mondi.
Uno sguardo plurale
Oriento queste mie riflessioni da più punti di osservazione: quello dell’ordinamento giuridico, costituzionale, che riconosce e deve garantire diritti a chi contingentemente abita il mondo dove la libertà personale è privata; quello del contesto sociale che indaga le ragioni di tale restrizione – che costituisce, o meglio dovrebbe costituire, misura estrema – e che deve saper attuare le possibilità di un positivo recupero di ogni persona verso l’autodeterminazione del proprio movimento e del proprio tempo; non per ultimo, dal punto di osservazione di chi ritiene che riconoscere l’appartenenza all’unico corpo sociale anche delle parti più difficili, conflittuali o supposte malate, è elemento essenziale per la comprensione di quelle altre parti del proprio sé supposte sane.
Sono punti di osservazione diversi che riassumono lo sguardo complessivo del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale: Istituzione giovane, attiva solo dal 2016, che deve avere proprio una pluralità nello sguardo rivolgendosi al vasto mondo delle persone a cui il bene della libertà è precluso, perché tale situazione soggettiva determina una maggiore vulnerabilità, per il rischio sia di una totale desocializzazione, sia di una minore effettività di quei diritti che pure l’ordinamento prevede.
Una pluralità dello sguardo che è motivata innanzitutto dall’ampiezza del panorama delle forme in cui la privazione della libertà personale può manifestarsi e che però richiedono criteri unificanti di lettura, perché l’accentuazione della vulnerabilità intrinseca alla restrizione in un luogo è indipendente dalle ragioni che motivano tale situazione: da chi è ristretto sulla base di un provvedimento di natura penale per ciò che ha commesso o che si suppone abbia commesso, a chi lo è temporaneamente da parte delle Forze di polizia in attesa di una convalida dell’Autorità giudiziaria, a chi lo è invece su base amministrativa per l’irregolarità della propria presenza nel territorio nazionale e attende l’esecuzione di un provvedimento che lo respinga ponendo fine al suo desiderio di costruzione di un ‘altrove’ sperato; fino a chi è privato della possibilità dell’agire autonomamente per un trattamento sanitario obbligatorio o per il suo temporaneo ricovero in un servizio psichiatrico ospedaliero chiuso. E, infine, chi è divenuto privato della libertà de facto senza un provvedimento dell’Autorità giudiziaria o amministrativa rispetto al quale possa ricorrere, ma semplicemente a causa delle contingenze della vita, per età o per disabilità, essendo ospitato in residenze sanitarie in cui è liberamente entrato e poi, per una molteplicità di ragioni, non goda più di un supporto all’espressione di quel suo irriducibile residuo di autonomia. Gli eventi dell’ultimo anno, vissuto nell’eccezionalità della pandemia e della conseguente chiusura al flusso di figure esterne portatrici di attenzione e sostegno, hanno accentuato il rischio di una fisionomia impropriamente restrittiva di queste residenze, oltre a creare spazi nuovi – per esempio, le navi per la quarantena di persone migranti – che hanno assunto questa configurazione.
Oltre che l’ampiezza della sua attività di vigilanza, è la stessa impostazione preventiva e non reattiva del Garante nazionale a richiedere la molteplicità del suo sguardo. Perché questa Istituzione, sviluppatasi lungo un ventennale dibattito con qualche eco dell’antica Regelis Form – la legge costituzionale svedese del 1809 – che prevedeva per prima una figura di Ombudsman, autonoma e autorevole, in grado di promuovere le istanze del cittadino di fronte alle Istituzioni, non ha preso la via della difesa civica, quale risposta reattiva a possibili violazioni nei confronti delle attese e degli interessi del singolo. Ha preso invece la via di un organismo preventivo, sulla base di un modello fortemente portato avanti dal Consiglio d’Europa caratterizzato dall’indipendenza e dal dialogo con l’Autorità giudiziaria a cui compete l’obbligo di reazione laddove un diritto sia stato violato. Una istituzione di controllo e cooperazione che non centra la propria azione sui singoli casi, ma sulla valutazione globale della tutela dei diritti nelle diverse realtà restrittive.
Il suo compito è, infatti, vigilare sulle diverse strutture privative della libertà personale con sguardo prospettico, volto a individuare quelle lacune normative, quelle applicazioni incongrue delle norme, quelle condizioni materiali, quelle culture diffuse che possano essere produttrici di violazioni di diritti: agendo ex ante e non dopo che tali violazioni si siano manifestate. Da qui la complementarità nell’analisi e nell’azione con l’Autorità giudiziaria a cui compete l’azione ex post, perché elemento cardine di ogni azione preventiva è il potersi fondare sulla capacità reattiva del sistema laddove le violazioni siano avvenute, anche al fine di non inviare alcun messaggio d’impunità.
L’esperienza europea d’altronde ha portato, più di trent’anni fa e sulla spinta di Antonio Cassese, ad affiancare alla Convenzione per i diritti umani del 1950, un altro strumento convenzionale relativo alla prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, istituendo un Comitato indipendente col compito di visitare con continuità i diversi luoghi dove le persone sono ristrette – per qualsiasi ragione o in virtù di qualsiasi provvedimento – al fine di individuare le possibili criticità e formulare raccomandazioni tali da evitare il loro nefasto evolversi. Un nuovo strumento convenzionale , questo, centrato su quell’articolo della Convenzione per i diritti umani che tocca il nodo della privazione della libertà personale e il Comitato istituito ha sviluppato nel corso della pluridecennale attività un insieme di raccomandazioni e standard – che comunemente indichiamo come sistema di soft law – che affianca il sistema delle sentenze della Corte di Strasburgo a cui compete l’azione reattiva rispetto alle violazioni avvenute e accertate e il cui corpus giurisprudenziale costituisce l’espressione dell’altro impianto di tutela, il cosiddetto hard law.
Due sistemi dialoganti quale modello di rafforzamento della tutela: un modello ripreso dal nostro Paese – proprio con la fisionomia data al Garante nazionale – e consolidato con l’adesione a un altro parallelo strumento convenzionale in ambito delle Nazioni Unite , rispetto al quale l’Italia ha indicato il Garante nazionale come proprio organismo indipendente in grado di esercitare vigilanza e al contempo collaborare sia con la Magistratura per i necessari accertamenti, sia con le Amministrazioni responsabili per la soluzione dei problemi eventualmente emersi dalla propria attività.
Da qui, lo sguardo ampio, prospettico e continuo del Garante: ampio nella estensione verso le diverse forme che configurano una privazione della libertà personale, sia essa de iure o de facto, prospettico nella capacità di individuare il potenziale germe dell’evolversi negativo di una situazione in termini di affievolimento della tutela dei diritti delle persone ristrette, continuo nel mantenere sotto costante attenzione la produzione normativa primaria e secondaria e la sua applicazione e soprattutto nel visitare in modo non annunciato e sistematico le strutture di varia configurazione che ospitano persone private della libertà da parte dell’autorità pubblica. Perché da questa capacità di vedere nasce l’efficacia concreta della sua azione e dei suoi pronunciamenti. Riprende quel «bisogna aver visto» a cui Pero Calamandrei richiamava nel sostenere, nella seduta del 27 ottobre 1948 della Camera dei deputati, il proprio ordine del giorno sulla previsione di una Commissione d’indagine sulle carceri e sulla tortura .
La restrizione in carcere
Con questa tensione preventiva e attraverso la sistematicità delle proprie visite, il Garante nazionale pone l’attenzione ai diritti delle persone ristrette e alla possibilità del loro concreto esercizio. E al contempo alla materialità delle condizioni di detenzione. Perché, come già ricordato agli albori della riforma penitenziaria ormai quarantaseienne «i parametri giuridici non valgono da soli a costituire la base per un effettivo godimento dei diritti. Una visione non formalistica della posizione dell’individuo nell’ordinamento giuridico convince che la previsione legislativa deve trovare conferma nelle condizioni di vita dell’individuo stesso». Del resto, «all’individuo libero, pur nella limitatezza dei mezzi che un sistema sociale può offrire, si presentano possibili alternative per la soddisfazione dei suoi diritti e l’uso non circoscritto di possibili risorse, per dare sostanza concreta alle previsioni della legge». Nella vita detentiva, invece, l’autonomia per l’espletamento delle condizioni di fatto che sostanziano il diritto è limitata e spetta all’Autorità che detiene la persona creare le condizioni per la realizzazione dei presupposti che integrano le previsioni della legge. «Sarebbe pertanto inutile e contro¬producente realizzare un sistema penitenziario avanzato quanto al riconoscimento formale dei diritti dei detenuti, quando non si curasse il contemporaneo avanzamento degli aspetti sostanziali della vita detentiva» .
L’obiettivo è, quindi, la riduzione della persistente distanza che separa i diritti affermati e i diritti agiti nella concretezza di questi luoghi implicitamente poco trasparenti. In primo luogo in carcere, emblematicamente rappresentativo di un mondo troppo spesso chiuso in sé stesso, visibile solo al suo interno e opaco all’esterno, perché questa è ancora la logica che ne governa regole, ritmi e quotidianità, anche nelle situazioni migliori, perché se è vero che il progetto claustrofilo di Jeremy Bentham non è ovviamente più né nella realizzazione architettonica né nel controllo totalizzante, è altrettanto vero che esso persiste frequentemente nella rappresentazione mentale con cui la comunità esterna dei non rei guarda al mondo che accoglie gli autori di reato. Le espressioni linguistiche con cui i mezzi d’informazione e il dialogo pubblico parlano del carcere sono un indicatore di tale rappresentazione e del residuo di teatralità della punizione che tuttora connota il rinchiudere una persona in un carcere senza interrogarsi sulla finalità della punizione, ma affidandosi all’implicita rassicurazione della chiusura.
La riflessione sui diritti delle persone ristrette in carcere richiede tuttavia alcune preliminari osservazioni. La prima riguarda l’assoluta centralità tuttora attribuita alla reclusione nel nostro sistema sanzionatorio. La seconda riguarda la difficile compatibilità dell’attuale situazione con i principi di sussidiarietà, equità e utilità che devono governare la reazione dello Stato alla commissione di un reato. La terza, l’intrinseco limite del carcere come luogo di esecuzione di una pena costituzionalmente orientata. Sono – io credo – le premesse per comprendere gli ambiti dei diritti delle persone che eseguono una pena in carcere e le difficoltà che oggi riscontriamo nel garantirne efficacemente l’esercizio.
Come è noto, il Costituente, nel trattare di sanzione penale nel terzo comma dell’articolo 27, utilizza il plurale e parla, appunto, di «pene», implicitamente prefigurandone una varietà come risposta alla commissione di un delitto, all’interno della quale collocare anche la pena detentiva. In realtà, la possibilità di pene alternative alla reclusione resta appesa alla predisposizione e all’adozione di un nuovo codice penale – esercizio che ha visto il lavoro di più commissioni, mai giunto all’esito di approvazione parlamentare. Attualmente, la centralità, se non l’unicità, è posta sulla pena detentiva, eventualmente contenuta attraverso un insieme di misure alternative, che dovrebbero configurarsi come tappe di un graduale e controllato percorso di reinserimento sociale, ma che rischiano invece di essere percepite dalla collettività come mere attenuazioni dell’afflizione detentiva. D’altra parte, la popolazione detenuta è sempre più connotata dalla preponderanza di autori di reato che eseguono sentenze di breve durata e che entrano in carcere con frequente ripetitività: alla data odierna circa mille persone sono in carcere per scontare una pena inflitta della durata inferiore a un anno e altre più di duemila una pena compresa tra uno e due anni: l’impossibilità di sviluppare un percorso rieducativo all’interno del mondo chiuso del carcere per periodi così brevi è evidente e rischia per un settore considerevole di persone ristrette di configurare la tendenza rieducativa, di cui parla il citato comma, come mera ipotesi, quasi un «feticcio rassicurante», secondo l’affermazione di un grande analista della detenzione scomparso, quale Massimo Pavarini. Certamente pene di tipo diverso, di carattere reintegrativo, interdittivo o propositivo, di utilità sociale, potrebbero avere maggiore incisività rispetto al rischio di reiterazione del reato.
Questa configurazione della composizione del mondo della detenzione, in cui la grande maggioranza sconta pene brevi e ripetute apre alla necessità del ritorno al carattere di sussidiarietà che dovrebbe configurare l’intervento penale, quale attore di ricomposizione che agisca laddove altri strumenti hanno fallito. Carattere oggi difficilmente rintracciabile non solo nella carenza di ‘luoghi’ deputati a un ruolo di costruzione di reti sociali forti che agiscano anche con valore educativo, ma anche nella pervasiva idea che il valore attribuito a un bene giuridico si misura con la durata della pena inflitta a chi tale bene aggredisce. Ma non solo la sussidiarietà è posta in questione, perché anche il carattere di equità vacilla quando, nonostante la presenza di misure che permettono di avere accesso a forme alternative alla detenzione per pene molto brevi, si registra una presenza così alta di persone che a esse non accedono. Non vi accedono perché prive di una rete sociale di supporto o di una difesa adeguata o anche per non conoscenza di tali possibilità: la differenza sociale che ne caratterizza la vita esterna trova un’amplificazione nella relazione con il sistema della giustizia penale e con la previsione sanzionatoria piuttosto che trovare un fattore di riduzione delle differenze.
Da qui, la presenza ripetuta di brevi detenzioni per reati seriali anche di minore rilevanza ma di forte incidenza sulla percezione di sicurezza collettiva o per reati connessi a stili di vita e a norme che si confrontano con essi solo sul piano della proibizione e della punizione conseguente: il numero di persone in carcere per detenzione e spaccio di lieve entità di sostanze psicotrope ne è visibile prova. Da qui, in un carcere così configurato, anche il vacillare dell’ipotesi utilitarista della giustificazione della pena.
La crisi del modello di welfare che si è compiuta con la drastica riduzione di servizi in grado di prevenire e armonizzare il disagio economico e individuale, oltre a respingere di fatto al di là delle mura della segregazione ciò che è rimasto privo di reti solide di sostegno, non solo materiale, ha reso spesso privo di significato il termine ‘rieducazione’ nella concretezza dell’esecuzione penale: l’utilitarismo non regge di fronte a talune condizioni. Quindi, un utilitarismo distorto che non raggiunge l’obiettivo che si è dato e resta soltanto formale, declaratorio. Ma, al contempo, anche il venire meno di una qualsiasi prospettiva retributiva perché il tempo ciclicamente sottratto non assume neppure tale valore e il criterio retributivo non è più parametro per una determinazione penale che si enuclei in un sistema di garanzie, ma solo per una determinazione penale che rimane come simbolo rassicurante e aggressivo di una crescente richiesta di castigo.
Difficile, quindi, rendere giustizia attraverso il tempo della detenzione, non più ancorabile alle tradizionali macro-teorie che hanno tenuto campo a lungo nel dibattito sulle pene e sulla detenzione: da un lato, infatti, il radicarsi ormai di un «correzionalismo in crisi» che propone solo formalmente come utile e trattamentale la pena detentiva, essendo in realtà mero tempo vitale sottratto e solo espressione del desiderio di un controllo disciplinare; dall’altro, il parallelo affermarsi di un «retributivismo distorto» , sensibile alla richiesta punitiva in termini di meritevolezza del castigo secondo il criterio che una supposta opinione pubblica ritiene come la pena giusta: quindi, un retributivismo fortemente eticizzato .
Rendere è, del resto, verbo impegnativo posto a fianco alla giustizia. Perché chiama in campo tutti gli attori coinvolti in quella lesione che la commissione di un delitto determina nel tessuto relazionale: l’autore, la vittima, ma anche e fortemente la collettività, perché nulla può esser ristretto alla logica binaria di chi commette il reato e chi direttamente lo subisce. Tutti devono trovare che quel rendere giustizia parla loro direttamente perché certamente Dike non può cancellare quanto commesso, né le colpe, ma ne deve rimediare gli effetti «ripristinando equilibri che siano stati turbati» .
Ancora più difficile il rendere giustizia quando l’orizzonte degli interventi normativi e amministrativi sul carcere è solo quello dell’oggi e dentro e non quello del domani e fuori. Eppure solo questa seconda diade dà significato alla restrizione in carcere e, comunque, a ogni punizione perché questa deve sempre avere la dimensione del futuro. In primo luogo nella direzione del non volere che quanto avvenuto possa ripetersi, ma parallelamente nella direzione della ricomposizione del tessuto ordinato che il reato ha spezzato, riannodando fili lacerati, recuperando così per la sanzione penale una dimensione non meramente inibente, ma in grado di ricostruire. Una giustizia che sappia ristorare.
Mi piace, in questo contesto, citare le parole di Protagora, nella elaborata descrizione che Platone riporta e che noi oggi possiamo leggere come deterrenza e rieducazione: «Chi cerca di punire ragionevolmente castiga non a causa dell’ingiustizia trascorsa, poiché non potrebbe ristabilire come non avvenuto ciò che è stato fatto, ma in vista del futuro, affinché né il colpevole, né chi lo vede punire commettano più ingiustizia» .
Un insieme incomprimibile di diritti
Se questo è il quadro entro cui discutere delle pene e della loro esecuzione, la fisionomia della pena scontata nel nostro Paese mostra carenze e criticità ben superiori a quelle che comunemente emergono quando il dibattito sul carcere è circoscritto al tema, indubbiamente rilevante, del sovraffollamento. Il limite maggiore, infatti, è nella mancanza di un’idea complessiva sul significato dell’esecuzione penale che in esso si attua. Certamente occorre intervenire per migliorare molti aspetti della materialità quotidiana del vivere interno e, tra questi, la costrizione in spazi angusti e densi di altre difficili vite. Ma la centralità della crisi è nello scarso interesse verso una risposta alla commissione di un delitto che non sia solo sottrattiva, che abbia una dimensione progettuale, che possa avere una parte, in taluni casi anche ampia, di privazione della libertà personale e che però non perda la finalità di un ritorno consapevole e diverso al contesto esterno nonché una visione del percorso per giungere a tale meta.
In questo percorso, il riconoscimento dei diritti della persona ristretta gioca un ruolo essenziale perché connota la costruzione di uno spazio di legalità sperimentata che ne è precondizione.
Non vi è dubbio che i diritti della persona in quanto tale siano incomprimibili in qualsiasi situazione di liberi o ristretti. Sono diritti che innanzitutto ruotano attorno a due assi: la dignità e l’integrità fisica e psichica. Due assi riassunti dall’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani – quello che vieta tortura e trattamenti o pene inumani o degradanti – e che, come già ricordato, è uno dei soli quattro articoli per i quali nessuna emergenza o situazione eccezionale può consentire una deroga . Ma sono anche i principi che emergono dalla lettura combinata dell’articolo 2, del primo comma dell’articolo 3 e della prima parte del terzo comma dell’articolo 27 della nostra Costituzione. Sempre alla luce del principio espresso dall’articolo 13 nel suo incipit sulla inviolabilità della libertà personale che definisce il perimetro entro cui si collocano le eventuali restrizioni, non escluse in via generale, ma sottoposte alle garanzie della riserva di legge e della riserva di giurisdizione. Mi piace ricordare che nel dibattito nell’Assemblea costituente fu Giuseppe Dossetti – con una proposta sostenuta anche da Palmiro Togliatti, Giovanni Lombardi e Aldo Moro – a volere tale enunciazione di principio come primo comma dell’articolo per definire il limite deontologicamente non superabile del successivo insieme regolativo – un insieme, questo, che egli definì come «norme pratiche a garanzia del diritto enunciato» – e per riverberarsi poi nell’articolo 27.
I due assi della tutela della dignità e della intangibilità fisica e psichica della persona inquadrano anche semanticamente gli altri diritti, a partire da quelli il cui riconoscimento e la cui tutela prescindono da specifiche condizioni contingenti – indipendentemente cioè dall’essere individuo libero o ristretto in carcere, presente in posizione di regolarità o di irregolarità nel territorio nazionale, ospitato o meno in strutture di vario tipo che ne limitano le possibilità di autodeterminazione. Mai annullando tale autodeterminazione perché di essa rimane sempre un residuo da riconoscere e potenziare, come ha ricordato la Corte costituzionale, anche esaminando situazioni di detenzione di tipo speciale, affermando che «chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo nel quale può espandersi la sua personalità individuale» .
Non sono soltanto questi i diritti che potremmo definire uti persona e per i quali la tutela di non degradazione a meri interessi legittimi non è ammissibile. In primo luogo il diritto alla tutela della salute – unico caso per il quale la Costituzione, certamente non prodiga di appellativi utilizza nel suo articolo 32 l’aggettivo «fondamentale» – che non è riassumibile nel solo diritto all’accesso alle cure, dovendo invece configurarsi in positivo verso la costruzione del ben-essere possibile anche nei luoghi caratterizzati dal mal-essere, quale è il carcere. Così come il diritto alla difesa (art. 24 e 111 Cost. e articolo 6 Conv.), alla manifestazione del proprio pensiero (articolo 21, primo comma Cost. e articolo 10 Conv.), alla informazione, alla comunicazione e alla sua riservatezza (articolo 15 Cost. e articolo 8 Conv.), all’espressione del proprio credo religioso (articolo 19 Cost e articolo 9 Conv.). Questi diritti possono trovare nel loro esercizio delle forme regolative, come la stessa Corte ha affermato in più sentenze , ma occorre sempre ricordare che, in quanto diritti, essi non costituiscono esplicitazioni del trattamento penitenziario suscettibili, quindi, di riduzioni meramente amministrative . Una configurazione, questa, che comporta che il bilanciamento tra beni costituzionali eventualmente confliggenti, quali sicurezza, effettività sanzionatoria e assolutezza dei diritti, sia fondato su criteri di ragionevolezza e che ogni limitazione sia adottata dall’Autorità giudiziaria e comunque sottoponibile a reclamo, secondo un procedimento di natura giurisdizionale conforme alle previsioni dell’articolo 111 della Costituzione.
Una particolare rilevanza riveste il diritto all’affettività e alla costruzione di un legame familiare (articoli 29, 30 Cost e articoli 8 e 12 Conv.), pur nella situazione nel nostro Paese che tuttora non riconosce all’interno della sua esplicitazione la possibilità di colloqui intimi con la persona partner. Un diritto che comunque richiede un ampliamento di riconoscimento ben superiore agli attuali limiti ai colloqui visivi e telefonici con i propri affetti; anche in questo caso ricordando le parole della Corte che sin dal 1979 ha rammentato che «è principio di civiltà giuridica che al condannato sia riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive, e garantita quella parte di personalità umana, che la pena non intacca» .
Accanto a questi diritti, vanno considerati quelli che competono all’individuo come parte attiva di una collettività, quali i diritti di espressione politica, di possibilità di manifestazione attiva del proprio pensiero, di petizione, di accesso all’istruzione anche a livello superiore, di rapporto di lavoro regolato e tutelato in modo non diverso da come previsto dal nostro ordinamento in via generale. Costituiscono un insieme per i quali la situazione di detenzione può comportare forme di specificità regolativa, ma la loro lettura – e la conseguente tutela – non va separata da quella che riguarda i cittadini nel loro complesso, perché altrimenti si realizzerebbe un disconoscimento generale delle posizioni soggettive sulla base della restrizione della libertà personale. È, infatti la stessa previsione costituzionale che attribuisce tali diritti alle persone libere a estendersi alle persone ristrette, modulandone ragionevolmente le forme ma lasciando integra la titolarità, senza alcuna distinzione di carattere fondativo tra i diritti che l’ordinamento penitenziario elenca e per i quali stabilisce le forme di agibilità e quelli che derivano dal riconoscimento costituzionale.
Quando l’ordinamento penitenziario, al suo articolo 4, recita che «i detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge» non evidenzia, infatti, un insieme separato di diritti, bensì postula il riconoscimento dei diritti del detenuto quale appartenente alla collettività, pur potendone limitare l’estensione e le forme di azione. Perché l’ordinamento penitenziario del 1975 abbandona la visione della cosiddetta «supremazia speciale» che determinava la soggezione della persona detenuta alla discrezionalità carceraria, producendo una crasi tra ordinamento interno e sistema ordinamentale generale: riporta a unità il quadro dei diritti.
L’unico diritto che è peculiare della situazione detentiva e che può legittimamente essere definito uti captivus risiede proprio nell’indicazione della seconda parte del più volte citato terzo comma dell’articolo 27 della Costituzione: è il diritto a che l’esecuzione penale sia effettivamente indirizzata alla finalità tendenziale che la Costituzione le assegna.
L’indicazione della finalità tendenziale non è una semplice opzione proposta dal Costituente, perché rappresenta il significato delle pene stesse. C’è voluto molto, anche dopo la riforma del 1975, perché questo principio fosse distintamente esplicitato: lo ha fatto con chiarezza la Corte costituzionale nel 1990 – quindici anni dopo l’approvazione dell’ordinamento penitenziario – affermando che troppo spesso tale finalità veniva «assunta in senso marginale o addirittura eventuale e, comunque, ridotta entro gli angusti limiti del trattamento penitenziario». Ma – scrive la Corte in quella sentenza – «se la finalizzazione venisse orientata verso quei diversi caratteri, anziché al principio rieducativo, si correrebbe il rischio di strumentalizzare l'individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione». E aggiunge: «È per questo che, in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stesse della pena» .
Proprio questa impostazione determina che la finalità costituzionalmente espressa configuri il diritto soggettivo a che la propria privazione della libertà sia strettamente e concretamente aderente a tale principio di legittimazione. Questa evidenziazione in termini di diritto soggettivo della significatività del tempo recluso e della sua diretta aderenza alla ragione che legittima la sottrazione di tempo della vita libera, non si pone soltanto per la privazione della libertà personale quale misura penale. Si riverbera su tutte le altre situazioni privative della libertà, anche di natura amministrativa o sanitaria: sempre la persona che vive contingentemente l’inibizione temporanea della propria autodeterminazione ha il diritto soggettivo a che tale misura sia strettamente coerente con la ragione in base alla quale l’ordinamento la prevede e l’autorizza – per un trattamento sanitario, una quarantena, una effettiva necessità d’indagine o altro – che mai sia un tempo meramente sottratto. Perché il tempo vuoto richiama l’altro vuoto: quello della non effettività dei diritti enunciati.
Il diritto a non essere anonimi
Voglio concludere questo rapido percorso del «diritto di avere diritti» – secondo il titolo di un importante libro di Stefano Rodotà – ricordando un diritto elementare a cui spesso prestiamo poca attenzione.
Rivolgendomi lo scorso anno al Parlamento, ho sottolineato che il primo diritto di ogni persona che è privata della libertà e che quindi vive la propria quotidianità in strutture chiuse, ove il rischio dell’esclusione incapacitante è sempre presente, è il diritto al proprio nome. Sono istituzioni, infatti, in cui spesso prevalgono le valutazioni statistiche, numeriche, perdendo il germe di quella soggettività di cui ognuno è portatore.
L’anonimia della persona è, infatti, il rischio maggiore di tutte le collettività ristrette.
Il diritto al nome implica il pieno riconoscimento come persona con quelle connotazioni che tale concetto porta con sé nella nostra Costituzione: non una caratterizzazione monadica, meramente soggettiva, bensì relazionale.
Grazie.
16 aprile 2021